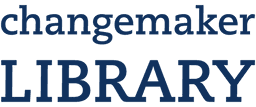Changemaker Library utilizza i cookie per fornire funzionalità avanzate e analizzare le prestazioni. Cliccando su "Accetta", acconsenti all'impostazione di questi cookie come indicato nella Cookie Policy. Fare clic su "Declino" potrebbe causare il mancato funzionamento di parti di questo sito come previsto.
Carlo PetriniItalia • Slow Food
Ashoka Fellow dal 2008
Ashoka Fellow dal 2008
La catena di approvvigionamento alimentare globale è rotta. Il cibo a basso costo è sovvenzionato attraverso un processo di esternalizzazione dei costi che serve solo le più grandi organizzazioni multinazionali e crea impatti ambientali e sociali negativi. I piccoli produttori di tutto il mondo vedono messo a repentaglio il loro modo di vivere. I consumatori trovano sempre più difficile conoscere la fonte e la nutrizione degli alimenti che acquistano. Carlo ha creato il movimento Slow Food per risvegliare i consumatori sia alla fonte del loro cibo che al valore gastronomico del cibo. Slow Food avvantaggia tutta la filiera: i produttori stanno accedendo a mercati sempre più ampi e di conseguenza stanno costruendo imprese sostenibili, preservando e ripristinando molte forme minacciate di produzione alimentare artigianale tradizionale. I consumatori si stanno riconnettendo con la fonte del cibo e le comunità del cibo che li circondano in un modo più sano e migliore per l'ambiente.
La persona
Nato a Bra, una regione rurale dell'Italia, Carlo ha studiato sociologia all'Università di Trento per poi dedicarsi alla politica locale e al lavoro associativo. Inizia a scrivere di enogastronomia nel 1977 collaborando con i maggiori quotidiani e periodici italiani. Carlo iniziò anche a ideare e organizzare eventi culturali. Carlo, nei primi anni '80, pone le basi per Arcigola, associazione il cui scopo era promuovere la cultura della convivialità e della buona enogastronomia, che si è poi trasformata in Slow Food. Dotato della capacità di anticipare gli eventi in campo alimentare, agricolo ed eco-gastronomico (termine da lui coniato), Carlo ha giocato un ruolo determinante nello sviluppo di Slow Food, inventando e promuovendone i progetti, che oggi hanno acquisito grande visibilità internazionale. In qualità di noto esperto del settore, Carlo ha scritto di temi come lo sviluppo sostenibile, la cultura materiale, la gastronomia e il rapporto tra cibo e ambiente, per molti importanti quotidiani e libri nazionali. È stato riconosciuto da The Guardian (gennaio 2008) come una delle 50 persone che potrebbero salvare il pianeta e da TIME Magazine Europe come "Eroe dell'anno" (2004). Anche la profondità dell'analisi teorica di Carlo sulla sostenibilità dell'alimentazione e dell'agricoltura in relazione alla gastronomia è stata riconosciuta dal mondo accademico. Nel 2003 l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli gli ha conferito la laurea honoris causa in Antropologia culturale e nel maggio 2006 ha ricevuto la laurea honoris causa in Lettere umane dall'Università del New Hampshire (USA) per i suoi successi come “... precursore rivoluzionario e fondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche. L'associazione Slow Food [di Carlo] ha risvegliato nel mondo l'interesse per la biodiversità gastronomica e agricola”.
La Nuova Idea
Carlo ha fondato Slow Food, un'organizzazione eco-gastronomica, in Italia nel 1986. Il suo obiettivo era contrastare la diffusione del fast food e la frenesia del fast food, la scomparsa delle tradizioni alimentari locali e l'indifferenza per ciò che mangiamo. Slow Food opera a livello globale per promuovere il cibo buono, pulito e giusto. In altre parole: il cibo che mangiamo dovrebbe avere un buon sapore, dovrebbe essere prodotto in modo da non danneggiare l'ambiente, il benessere degli animali o la nostra salute, e i produttori di alimenti dovrebbero ricevere un equo compenso per il loro lavoro. Carlo crede fermamente che le scelte alimentari di ogni consumatore abbiano conseguenze in tutto il mondo. Ha sviluppato il concetto di co-produttori, ovvero andare oltre il ruolo passivo di un consumatore e interessarsi a coloro che producono il nostro cibo, a come lo producono e ai problemi che devono affrontare nel farlo. Slow Food, inoltre, tutela la biodiversità alimentare, educa le persone al cibo e avvicina consumatori e produttori promuovendo canali di distribuzione alternativi. Carlo capì fin da subito l'importanza del valore gastronomico del cibo per cambiare i modelli di consumo, educando i consumatori a essere gli attori primari nella trasformazione dell'industria alimentare (un passo fondamentale verso un'agricoltura sostenibile e un ambiente migliore). Carlo crede che questa sia la migliore difesa contro cibi di scarsa qualità, prodotti in serie o adulterati, e anche contro cibi dannosi per l'ambiente e malsani nelle nostre diete. Risvegliando e formando i sensi dei consumatori, Slow Food aiuta le persone a riscoprire le gioie del mangiare i cibi locali e a comprendere l'importanza di prendersi cura della provenienza del cibo, di chi lo produce e di come è fatto. Slow Food tutela le cucine locali, i prodotti tradizionali e le specie vegetali e animali a rischio di estinzione, attraverso un percorso chiamato “educazione del gusto”. Carlo ha sviluppato programmi educativi per tutti: bambini e adulti, soci e non soci; con uno sforzo speciale per includere i giovani in questa trasformazione. Un altro importante ambito di lavoro di Carlo è la Fondazione Slow Food per la Biodiversità per la salvaguardia delle nostre risorse gastronomiche e per la difesa del nostro patrimonio mondiale di biodiversità agricola e tradizione gastronomica. La Fondazione Slow Food sostiene progetti a difesa della biodiversità alimentare in più di sessanta Paesi e promuove un'agricoltura sostenibile, rispettosa dell'ambiente, dell'identità culturale delle popolazioni locali e del benessere animale. Per rafforzare il campo riunendo tutti i vari attori coinvolti nell'industria alimentare, Carlo ha fondato Terra Madre, una rete globale di comunità del cibo, tra cui agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi ed esperti agrari, per scambiare idee, conoscenze ed esperienze , discutere il proprio lavoro e trovare possibili soluzioni a problemi comuni.
Il problema
Il 75% della diversità dei prodotti alimentari europei è andato perso dal 1900. Il 93% della diversità dei prodotti alimentari americani è andato perso nello stesso periodo di tempo. Il 33% delle varietà di bestiame è scomparso o sta per scomparire e 30.000 varietà vegetali si sono estinte nel secolo scorso, con una persa in più ogni sei ore. Questa tendenza è esacerbata dall'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) che abbagliano con la promessa di "super cereali" creati in laboratorio. Gli OGM sono presentati come una risposta naturale per nutrire la popolazione mondiale una volta che le colture attuali non saranno più sufficienti. Tuttavia, questo ci farà perdere il patrimonio vegetale che si è naturalmente adattato alle condizioni locali e la cui varietà fornisce salvaguardie in caso di malattie e carestie dovute ad eventi naturali. Perdiamo anche la conoscenza degli alimenti che ci hanno nutrito per secoli e, quindi, la capacità di nutrirci. Nel frattempo, i continui e insostenibili aumenti dei prezzi di grano (+120%), mais, riso (+75%), soia e altri prodotti stanno causando il caos in tutto il mondo, soprattutto nei paesi poveri in via di sviluppo dove la maggior parte delle persone spende più di metà del loro reddito sul cibo. L'aumento del consumo mondiale di carne (anche nei paesi dove la carne veniva consumata raramente) e il boom dei biocarburanti sono tra le principali cause dell'impennata dei prezzi, che non accennano a moderarsi. La situazione è ulteriormente aggravata dal calo della produzione mondiale e dal generale aumento della domanda di cibo. Dal momento che l'industria agroalimentare si è posizionata come il principale fornitore mondiale, la distribuzione è stata affidata alle aziende alimentari in modo che possano realizzare profitti. Ma i profitti non seguono le leggi della natura e questa incompatibilità ha conseguenze sociali e ambientali dirompenti. La Rivoluzione Verde ha ridotto l'agricoltura a monocolture di riso e grano che necessitano di dosi crescenti di fertilizzanti chimici, pesticidi e acqua per l'irrigazione. L'allevamento contadino è stato sostituito dall'allevamento industriale e l'agroecologia è stata sostituita dall'agricoltura industriale. L'ingegneria genetica, spesso definita la seconda rivoluzione verde, ha già ridotto l'agricoltura a mais, soia, colza e cotone, sulla base di due caratteristiche - resistenza agli erbicidi e colture di tossine - nelle mani di cinque giganti corporazioni. Quotidianamente le risorse mondiali vengono esaurite da questa nuova monocoltura intensiva. Molti di questi cambiamenti stanno avvenendo perché abbiamo dimenticato il valore insito nell'atto di produrre e consumare cibo. La sua importanza è stata erosa, riducendola al livello di qualsiasi altro prodotto di consumo che segue le regole di un'economia di mercato in contrasto con la natura. Oggi il mondo del cibo assomiglia alla catena di montaggio di un'azienda manifatturiera. Ad esempio, i Paesi Bassi sono diventati il principale esportatore mondiale di arance semplicemente perché hanno sviluppato la logistica più efficiente per distribuirle. Esaminando i dati forniti dal Dipartimento federale dell'agricoltura degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno esportato 20 milioni di dollari di lattuga in Messico e nello stesso anno hanno importato 20 milioni di dollari di lattuga dal Messico. Secondo il sito web della BBC, diversi pesci inglesi, una volta catturati, vengono inviati in Cina per essere lavorati e confezionati prima di tornare nel paese da cui provengono per essere venduti nei supermercati. Il sistema alimentare globale sembra aver perso completamente l'orientamento. Gran parte del viaggio che fa il nostro cibo è inutile, genera emissioni inquinanti e spreca energia, soffoca le reti di trasporto e ha un impatto negativo sulla qualità del cibo. Questo mostra i segni più evidenti della nostra moderna enfasi sull'efficienza. Salute, gusto, economie locali e ambiente passano in secondo piano rispetto a condizioni economiche prevalenti.
La strategia
Carlo ha fondato Slow Food per affrontare alcune delle questioni più urgenti create dall'industria alimentare globale. Slow Food è un movimento sociale con 100.000 iscritti in 132 paesi. La rete è organizzata in capitoli locali di volontari chiamati Convivia, che promuovono corsi, degustazioni, cene e campagne a livello locale. La rete mette in contatto anche i consumatori con i produttori locali e partecipa ai grandi eventi internazionali organizzati dall'associazione. Sono più di 1.000 le condotte Slow Food attive in 80 paesi. Il lavoro di Slow Food si articola in tre aree principali: sensibilizzazione ed educazione, tutela della biodiversità agroalimentare e aggregazione delle comunità del cibo, tra cui consumatori, agricoltori, allevatori, pescatori, trasformatori, distributori, cuochi ed esperti agrari. Carlo ha creato una rete di membri volontari che gli consente di ottenere tutto questo con meno di 150 dipendenti a tempo pieno e un budget di 25 milioni di euro (33,3 dollari USA). Il cibo buono, pulito e giusto è possibile solo con la conoscenza: conoscenza di chi porta il cibo in tavola e conoscenza di chi lo mangia. Capire di più sul nostro cibo, sul suo sapore e da dove viene, rende l'atto di mangiare ancora più piacevole. Il gusto è soggettivo, ma è anche qualcosa che si può acquisire e allenare. Lo sa bene l'industria agroalimentare, che tende a standardizzare il gusto. Per affrontare il fenomeno, che ha gravi conseguenze per i territori e gli stili di vita, Slow Food ha sviluppato programmi educativi in 60 Paesi. Nei laboratori del gusto gli esperti (i.e. cuochi, produttori, ecc.) insegnano ai partecipanti ad assaggiare e confrontare e quindi a “capire” i cibi. I programmi dell'orto scolastico danno ai bambini la possibilità di imparare "sul campo", all'aperto. Slow Food ha programmi educativi per tutti; bambini e adulti, soci e non soci. Un focus importante è posto sui programmi scolastici di Slow Food che vanno dalla formazione degli insegnanti e collaborazione ai curricula, al miglioramento della mensa scolastica e all'organizzazione di programmi di doposcuola. Dal 1998 circa 9.000 insegnanti delle scuole hanno partecipato ai corsi Slow Food, condividendo le loro conoscenze con migliaia di studenti e genitori in programmi di educazione del gusto. Questi programmi sono diversi da molti altri progetti di educazione alimentare perché non si limitano esclusivamente alla nutrizione. Sottolineano inoltre che il cibo significa piacere, cultura e convivialità, insegnano valori e atteggiamenti e migliorano le relazioni e le emozioni. Il materiale didattico, sotto forma di corsi, conferenze, conferenze e laboratori del gusto, è a disposizione degli insegnanti nelle loro classi. Slow Food ritiene inoltre che le università debbano svolgere un ruolo fondamentale nell'identificazione e nella comunicazione di conoscenze che si trasmettono principalmente oralmente e attraverso la pratica. Questa conoscenza è stata in qualche modo emarginata dalle informazioni che l'agrobusiness offre ai consumatori attraverso intelligenti campagne di PR. Le università possono svolgere un ruolo importante nell'educazione dei consumatori e nella promozione di sistemi sostenibili di ristorazione e approvvigionamento. Nel 2003 Slow Food ha fondato l'Università di Scienze Gastronomiche, unica istituzione al mondo nel suo genere, un centro internazionale di formazione e ricerca, al servizio delle persone che lavorano per una nuova agricoltura, il mantenimento della biodiversità, un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie. Carlo ha anche creato la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, a difesa del nostro patrimonio mondiale di biodiversità agraria e tradizione gastronomica. La fondazione sostiene diversi progetti tra cui l'Arca del Gusto, che reperisce, cataloga e nomina cibi tradizionali in pericolo e bisognosi di tutela, i Presìdi, che sostiene piccoli progetti a favore di gruppi di produttori sostenibili, e i Mercati della Terra, creati per portare consumatori e piccoli produttori sostenibili insieme. Slow Food rende reale il suo sostegno alla biodiversità promuovendo i produttori artigianali di prodotti di qualità. Creata nel 1996, l'Arca del Gusto è un catalogo in crescita di cibi dimenticati o emarginati e che rischiano di scomparire del tutto. L'Arca identifica quasi 800 razze animali, varietà di frutta e verdura, cibi preparati, piatti specifici e offre una risorsa per chi è interessato a reperire e promuovere cibi di qualità. Nel 2000, per aiutare direttamente i produttori alimentari artigianali, Carlo ha creato Presìdi che attualmente coinvolge più di 300 progetti in tutto il mondo. Questi progetti su piccola scala proteggono i metodi di produzione tradizionali sostenendo i produttori in loco e aiutandoli a trovare mercati per i cibi tradizionali. Con i Presìdi un po' di assistenza fa molto. Tutto ciò che serve è riunire i produttori, aiutarli a coordinare marketing e promozione e stabilire standard di qualità e autenticità per il loro prodotto. Altri prodotti richiedono uno sforzo maggiore per risparmiare. A volte è necessario costruire un caseificio o un forno o sviluppare nuovi modi di utilizzare o preparare un determinato alimento. I Presìdi Slow Food operano in modi diversi, ma gli obiettivi rimangono costanti: promuovere prodotti artigianali sostenibili, stabilizzare le tecniche di produzione, stabilire standard di produzione rigorosi e, soprattutto, garantire un futuro sostenibile per i cibi tradizionali e i piccoli produttori, in particolare nel Sud del mondo. Carlo ha compiuto uno sforzo importante per costruire il campo, concentrandosi su due aspetti: collegare i produttori ai consumatori e creare un'importante rete globale di comunità del cibo. Per favorire una più stretta interazione tra produttori e consumatori, Carlo ha lanciato il termine co-produttori per nominare l'atto di andare oltre il ruolo passivo di consumatore e interessarsi a chi produce il nostro cibo, come lo produce e i problemi che deve affrontare nel farlo. Supportando attivamente i produttori alimentari, i consumatori alterano la domanda di cibo e nel tempo possono alterare la produzione e l'offerta di cibo. Questi due gruppi sono tipicamente separati alle due estremità di una catena alimentare che negli ultimi cinquant'anni è diventata progressivamente più spersonalizzata, allungata e opaca. Il risultato è che chi produce cibo e chi lo mangia non si conoscono più, non si parlano, non si vedono o si stringono la mano. Slow Food organizza numerose fiere, eventi e mercati, per favorire una maggiore connessione tra produttori e co-produttori. L'altra importante iniziativa lanciata da Carlo nel 2004 è Terra Madre, una rete mondiale che riunisce comunità del cibo che lavorano per la sostenibilità e la qualità dei loro prodotti alimentari. Terra Madre mira a restituire dignità al lavoro di contadini, pescatori, allevatori e produttori di alimenti artigianali di tutto il mondo; salvaguardare il diritto dei popoli alla sovranità alimentare; e, per incoraggiare un modello sostenibile di produzione agroalimentare. Terra Madre combatte la standardizzazione del gusto, l'agricoltura industriale su larga scala e la manipolazione genetica e promuove la collaborazione tra produttori, cuochi e accademici per cambiare il modo in cui oggi viene prodotto il cibo. Ad ogni incontro di Terra Madre, che si tiene a cadenza biennale, i partecipanti partecipano a workshop e tavole rotonde dedicate ai problemi che incontrano quotidianamente e su temi più ampi, come la biodinamica e l'ingegneria genetica. Soprattutto, si incontrano per discutere il loro lavoro e le possibili soluzioni a problemi comuni. Di recente hanno partecipato 6.000 delegati in rappresentanza di 1.600 comunità del cibo provenienti da 150 paesi, tra cui agricoltori, allevatori, pescatori, trasformatori, distributori, cuochi ed esperti di agricoltura. Sulla base del successo degli incontri biennali di Terra Madre, Slow Food sviluppa anche, in collaborazione con partner locali, incontri regionali di Terra Madre. In questo modo si rafforzano le reti locali e più produttori hanno accesso al movimento Slow Food globale, connessioni con cuochi e accademici e maggiore visibilità nei propri paesi e comunità. Slow Food ha due organismi commerciali che controlla per l'autofinanziamento: Slow Food Promozione si occupa prevalentemente dell'organizzazione di grandi eventi come Salone del Gusto, Cheese e Slow Fish, oltre alla raccolta fondi, pubblicità e sponsorizzazione, e Slow Food Editore è responsabile delle attività editoriali dell'associazione, tra cui siti web, riviste associate e newsletter, oltre a oltre settanta guide enogastronomiche, saggi e libri di cucina.